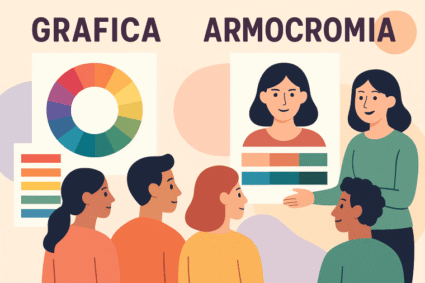Dall’8 al 15 luglio sarà una settimana speciale per i palermitani, poiché si festeggia la Santa Patrona della città, Santa Rosalia, affettuosamente chiamata dai cittadini la Santuzza.
Il Festino, come è chiamato l’insieme dei festeggiamenti, è considerata la festa più importante di Palermo e ha rappresentato un elemento di forte attrattiva e di grande suggestione per i letterati e gli artisti e, ai giorni nostri, per i turisti che, in quei giorni, si trovano a visitare Palermo in una straordinaria mescolanza tra sacro e profano delinea, quindi, l’espressione della grande devozione dei palermitani a Santa Rosalia.
Rosalia, vissuta nel XII secolo, durante la dominazione normanna, era figlia del duca Sinibaldo della Quisquina e delle Rose e nipote per parte di madre di re Ruggero d’Altavilla. Durante una battuta di caccia su Monte Pellegrino,
Ruggero fu salvato dall’aggressione di un leone dal principe Baldovino e, in premio, quest’ultimo chiese al re la mano di Rosalia.
Sentendosi consacrata al Signore, la giovane fuggì dal Palazzo Reale, vivendo da eremita prima sul monte della Quisquina, dove trascorse dodici anni e poi, fino alla morte, in una grotta su Monte Pellegrino.
Il culto della Santa si diffuse in tutta la Sicilia, come testimoniano i diversi esempi iconografici e le numerose chiesette e cappelle a lei dedicate fin dall’epoca medievale.
Ma il maggior impulso alla divulgazione della venerazione alla Santuzza avvenne quando una terribile epidemia di peste sconvolse Palermo, dal giugno 1624 al febbraio 1626 e sul Monte Pellegrino si scavava dato che, qualche tempo prima, una donna del popolo, Geronima La Gattuta, inferma per una grave malattia, aveva sognato una fanciulla in abito monacale che le aveva promesso la guarigione se si fosse recata in penitenza sul monte; qui giunta a sciogliere il voto, che le era apparsa nuovamente in sogno, indicandole una grotta in cui scavare per ritrovare il suo sepolcro. I
l 15 luglio, il marinaio Vito Amodeo fu il primo a trovare un teschio e numerose ossa incastrate in un grande masso e per tutti fu immediato il collegamento con Santa Rosalia.
Diffusasi la notizia del ritrovamento delle ossa, il cardinale Giannettino Doria: dispose che esse venissero trasportate e custodite nel Palazzo Arcivescovile in attesa di un attento esame per accettarne l’autenticità.
Il 13 febbraio 1625, il giovane Vincenzo Bonello, che aveva perso la moglie per il contagio, s’inoltrò su Monte Pellegrino per farla finita, ma incontrò una giovane pellegrina con un’aureola che gli disse di essere Rosalia, che le ossa ritrovate erano le sue e che la peste sarebbe cessata soltanto se esse fossero portate in processione per le strade della città, poi gli ordinò di riferire tutta al cardinale.
Il 22 febbraio, la Consulta medico-teologica proclamò il riconoscimento dell’autenticità delle ossa, poi trasferite in Cattedrale e il Senato decise che le reliquie dovessero essere custodite in un’urna d’argento, che fosse costruita una sontuosa cappella in cattedrale e un’altra su Monte Pellegrino e che il 15 di ogni anno l’urna dovesse essere portata in solenne processione.
Sotto la spinta dell’entusiasmo popolare, il 9 giugno dello stesso anno, il Senato organizzò una processione delle spoglie mortali della Santa nell’ambito di una sontuosa festa che durò nove giorni, durante i quali la città fu un tripudio di luci, broccati, arazzi, archi di trionfo, statue, festoni di fiori. La peste cominciò sensibilmente a decrescere e il 4 settembre 1625, giorno della nascita di Rosalia, fu pubblicato il bando che dichiarava la fine dell’epidemia.
Anche la grotta su Monte Pellegrino, dove furono rinvenute le ossa della santa, divenne immediatamente luogo di culto e ciò portò alla realizzazione di un Santuario a lei dedicato.
La maggior attrazione del 14 luglio è rappresentata dal Carro Trionfale, una macchina scenica realizzata per la prima volta nel 1686, alla cui sommità troneggia la statua di Santa Rosalia, coronata di rose, che percorre il Cassaro, ovvero via Vittorio Emanuele, fino a Porta Felice, accompagnato da musici e cantori, la giornata si chiude con gli spettacolari giochi pirotecnici a mare.
Il 15 luglio è dedicato alla festività religiosa con la processione dell’urna argentea, contenente le reliquie della Santuzza, lungo le vie del centro storico.
La devozione palermitana per Rosalia è legata a due date, il 15 luglio e il 4 settembre.
A metà luglio, è la Santa a scendere in città circondata dall’amore e dalla devozione di migliaia di persone e il 4 settembre sono i palermitani che ricambiano la visita, quando fanno l’acchianata, cioè si dirigono lungo l’antica strada che dalle falde porta alla grotta sul Monte Pellegrino.
Il luogo deputato dell’incontro tra la Santa e la cittadinanza, nel Festino di luglio, è il Foro Italico che, per l’occasione si riempie di bancarelle con i mulunari con le angurie che galleggiano nelle vasche di acqua ghiacciata, i venditori di fichi d’india, i venditori di calia e simenza, ovvero ceci tostati e semi di zucca, oltre ai luppini, le fave secche tostate, i cruzziteddri (castagne secche), la cubbaita (dolce di zucchero), la mandorlata e la nocciolata, ma il Festino è il trionfo dei babbaluci, cioè le lumache.